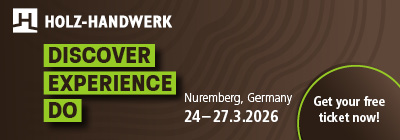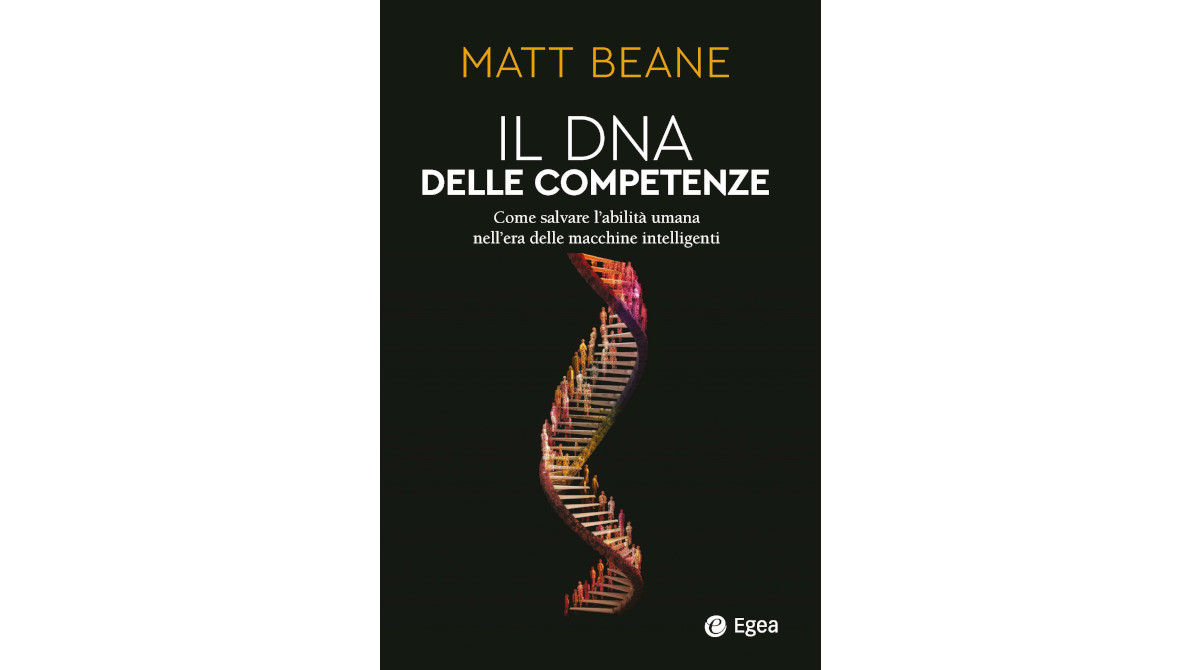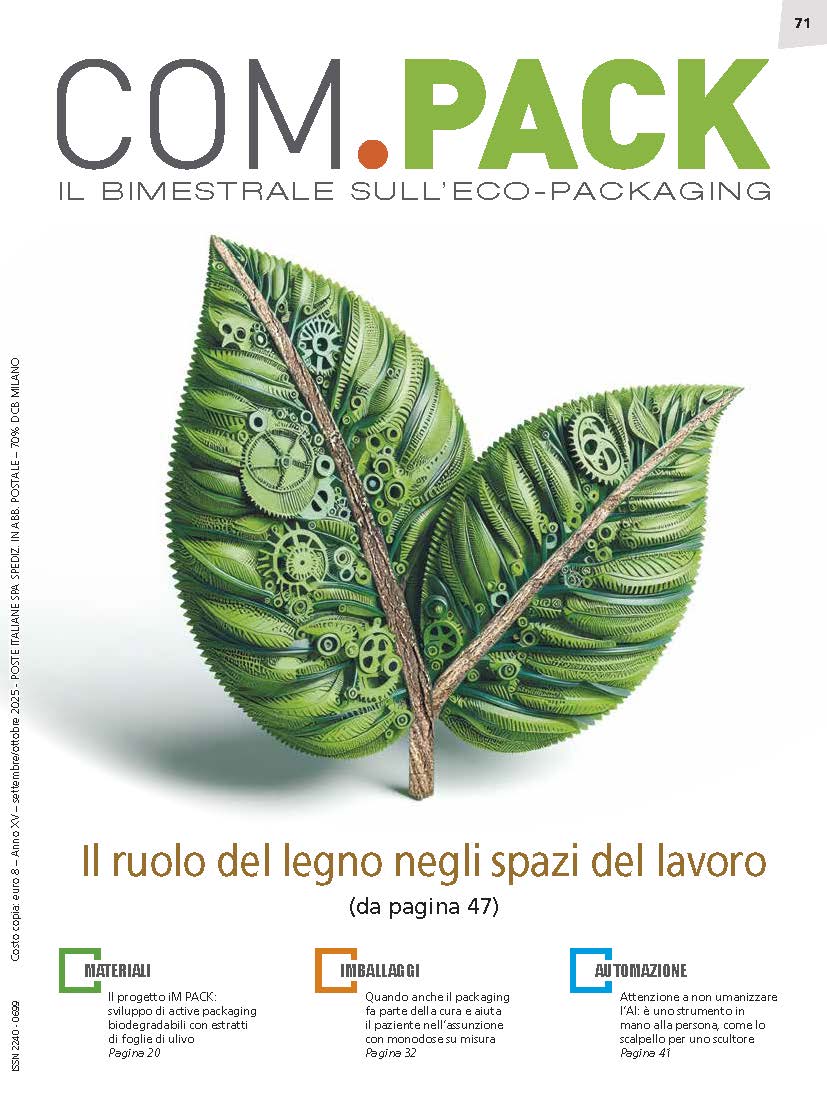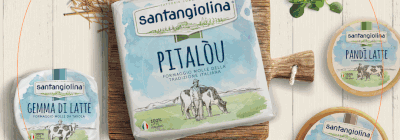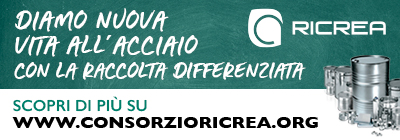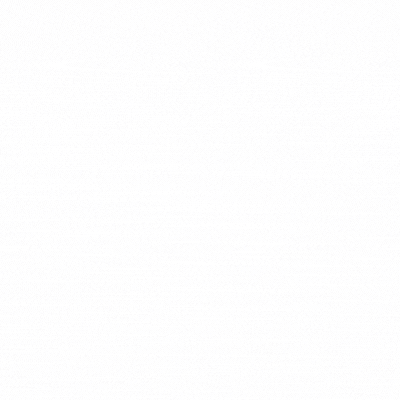In che modo l’intelligenza artificiale e le derive del digitale minacciano le abilità umane, e come è possibile reagire? Il tecnologo Matt Beane risponde a queste domande nel nuovo saggio “Il dna delle competenze”, tradotto in Italia dalla casa editrice Egea e in libreria da pochi giorni. Nel volume, Beane condivide i risultati di un decennio di ricerche sul campo per comprende se e come è possibile salvare le abilità umane nell’era delle macchine intelligenti.
Ricercatore e tecnologo, docente presso il dipartimento di Technology Management dell’Università della California, Beane ha trascorso gli ultimi dieci anni a studiare come funziona il dna delle competenze umane in una varietà di ambienti, dai magazzini alle sale operatorie. Ha scoperto che – proprio come i quattro aminoacidi sono gli elementi costitutivi del Dna – sfida, complessità e connessione sono le componenti fondamentali del modo in cui sviluppiamo le nostre abilità più preziose.
Le nuove tecnologie stanno erodendo la nostra capacità di sviluppo personale e relazionale. La facilità di accesso alle informazioni e l'immediatezza dei dispositivi digitali stanno riducendo la nostra soglia di attenzione e la capacità di affrontare sfide complesse. Quel che è peggio, stiamo compromettendo il legame tra esperti e principianti che resiste da 160.000 anni. Oggi le tecnologie intelligenti vengono utilizzate per ampliare le capacità dei professionisti, finendo per escludere i novizi dall'apprendimento sul campo. Un chirurgo robotico può operare quasi completamente da solo, un banchiere può analizzare dati tramite l’Ai, un magazziniere viene affiancato da robot che riducono al minimo il suo coinvolgimento attivo. Questo processo non elimina semplicemente posti di lavoro, ma dequalifica le competenze, impedendo ai giovani di acquisire quelle abilità che si apprendono solo attraverso un'esposizione diretta e una guida esperta. La posta in gioco? Oggi le competenze personali, domani il patrimonio di conoscenze di una professione.
Il declino, secondo Beane, non è inevitabile e l’autore propone una serie di strategie che consentano di coltivare l’abilità anche nell’era delle macchine, come riallineare i ruoli lavorativi per riconnettere esperti e principianti, modificare i parametri di valutazione per premiare l'apprendimento, attingere al know-how della prima linea e limitare la sorveglianza eccessiva abilitata dalla tecnologia. E poi gli “apprendenti ombra”: individui che nelle difficoltà trovano strade alternative – talvolta oltre i limiti delle regole – per sviluppare competenze. Non un punto di riferimento, insomma, ma un esempio da cui mutuare alcune strategie.
Beane non perde la fiducia in una tecnologia che riesca a mettere in risalto le nostre abilità, invece di sgretolarle: da un caso di studio concreto come quello degli artificieri, che utilizzano un robot per addestrare i nuovi operatori in tutta sicurezza, fino alla creazione di “piattaforme chimeriche” che combinino intelligenza umana e artificiale per sviluppare nuove infrastrutture di apprendimento, preservando sfida, complessità e connessione in un mondo sempre più digitale.
“Per quanto portentoso e assolutamente indispensabile possa apparire per la nostra abilità un futuro chimerico, l’unico modo in cui può diventare realtà è attraverso il nostro lavoro, le nostre relazioni e le nostre scelte”, scrive Matt Beane. “Nell’insistenza quotidiana sull’eccellenza che anima il legame collaborativo tra esperti e principianti. Nella sofferenza e negli sprechi che si creano quando indeboliamo questo legame per perseguire una produttività abilitata dalla tecnologia. Nell’ingegno e nella grinta dell’apprendimento ombra che crea abilità nonostante le barriere. Abilità che lasciano tracce salubri in ciascuna tappa successiva del viaggio, e a cui dobbiamo prestare la massima attenzione se vogliamo dare forma a un futuro migliore. Ma dovremo essere in molti a sposare la causa se non vogliamo che tutto ciò cada nel vuoto”.